Cicale
Un percorso tematico
di
Giulia Regoliosi Morani
(da Zetesis 2004-2, con aggiunte e
integrazioni)
Indice:
1. L'estate
2. Il
canto
3. Otium e negotium: la rilettura
moralistica
4. La vecchiaia
1. L’estate
Le cicale sono
uno degli elementi topici che identificano l’estate: il loro canto è
connesso con la calura, l’aridità, l’arsura, la ricerca di ombra e
ristoro, e ne costituisce il sottofondo sonoro, spesso l’unico.
a) L’archetipo
è un passo esiodeo:
Esiodo, Le
opere e i giorni, vv. 582 segg.:
Ἧμος δὲ
σκόλυμός τ' ἀνθεῖ καὶ ἠχέτα τέττιξ
δενδρέῳ ἐφεζόμενος λιγυρὴν καταχεύετ' ἀοιδὴν
πυκνὸν ὑπὸ πτερύγων, θέρεος καματώδεος ὥρῃ,
τῆμος πιόταταί τ' αἶγες, καὶ οἶνος ἄριστος,
μαχλόταται δὲ γυναῖκες, ἀφαυρότατοι δέ τοι ἄνδρες
εἰσίν, ἐπεὶ κεφαλὴν καὶ γούνατα Σείριος ἄζει,
αὐαλέος δέ τε χρὼς ὑπὸ καύματος· ἀλλὰ τότ' ἤδη
εἴη πετραίη τε σκιὴ καὶ βίβλινος οἶνος ...
Quando il
cardo fiorisce e l’echeggiante cicala appollaiata su un albero riversa
il suo canto melodioso muovendo fittamente le ali, nella stagione della
faticosa estate, allora le capre sono più grasse, il vino più buono, le
donne più dissolute, gli uomini più fiacchi, perché Sirio inaridisce
testa e ginocchia, e la pelle è secca per la calura: ma allora vi sia
l’ombra di una roccia e vino di palma ...
b) La
descrizione viene ripresa da Alceo: notiamo come il mutamento formale (eolico invece di ionico,
asclepiadei maggiori invece di esametri) non impedisca l’imitazione,
anche se vi sono degli spostamenti: ad esempio l’idea del canto
echeggiante della cicala è resa da Esiodo con un attributo, da Alceo
con il verbo corradicale. Il fondamentale spostamento riguarda il tema
di fondo: la descrizione del ciclo della natura in Esiodo, il tema
simposiaco in Alceo. Di qui la collocazione alla fine o all’inizio
dell’invito al ristoro.
Fr. 347 V:
τέγγε
πλεύμονας οἴνωι, τὸ γὰρ ἄστρον περιτέλλεται,
ἀ δ' ὤρα
χαλέπα, πάντα δὲ δίψαισ' ὐπὰ καύματος,
ἄχει δ' ἐκ πετάλων ἄδεα τέττιξ ...
ἄνθει δὲ σκόλυμος, νῦν δὲ γύναικες μιαρώταται
λέπτοι δ' ἄνδρες, ἐπεὶ < > κεφάλαν καὶ γόνα
Σείριος
ἄσδει
Bagna i
polmoni col vino, infatti l’astro compie il suo giro, e la stagione è
terribile, e tutte le cose hanno sete per la calura, ed echeggia dalle
foglie dolcemente la cicala, e fiorisce il cardo, e ora le donne sono
più turpi e gli uomini smunti, perché Sirio inaridisce testa e ginocchia
c) Anche la cornice paesaggistica del Fedro platonico comprende
le cicale all’interno di un’ampia descrizione di un locus amoenus
estivo (riportiamo solo la parte finale):

Platone, Fedro, 230
τὸ εὔπνουν τοῦ τόπου ὡς ἀγαπητὸν καὶ σφόδρα ἡδύ θερινόν τε
καὶ λιγυρὸν ὑπηχεῖ τῷ τῶν τεττίγων χορῷ. πάντων δὲ κομψότατον τὸ τῆς
πόας, ὅτι ἐν ἠρέμα προσάντει ἱκανὴ πέφυκε κατακλινέντι τὴν κεφαλὴν
παγκάλως ἔχειν. ὥστε ἄριστά σοι ἐξενάγηται, ὦ φίλε Φαῖδρε.
Com’è amabile e dolcissima la gradevole
aria del luogo! Qualcosa di estivo e melodioso echeggia nel canto delle
cicale. Ma la cosa più piacevole di tutte è l’erba, che in leggero
pendio riesce a sostenere benissimo la testa per chi vi si sdraia. Sei
una guida eccellente, caro Fedro.
d)
In Virgilio incontriamo due scene estive, in cui compare il topos delle
cicale. In un passo delle Georgiche che si colloca nella
tradizione esiodea l’estate è identificata dai due elementi
sete/cicale. Dato il tema generale del III libro (l’allevamento del
bestiame) la calura e il ristoro sono visti solo in funzione degli
animali:
Georg. III, 327 segg.
inde ubi
quarta sitim caeli collegerit hora
et cantu querulae rumpent arbusta cicadae,
ad
puteos aut alta greges ad stagna iubebo
currentem
ilignis potare canalibus undam.
Poi,
quando l’ora quarta del cielo accumulerà la sete e le cicale lamentose
eromperanno attraverso gli arbusti col loro canto, inviterò a portare
le greggi presso i pozzi o gli stagni profondi, a bere l’acqua che
scorre nei canali di legno di leccio.
Invece
nel seguente passo della seconda ecloga protagonista è l’uomo
(Coridone), per cui la calura estiva aggiunge sofferenza al dolore di
un amore non corrisposto:
Ecl. II, 8 segg.
Nunc etiam pecudes umbras et frigora captant,
nunc viridis etiam occultant spineta lacertos,
Thestylis et rapido fessis messoribus aestu
alia serpyllumque herbas contundit olentis.
At
mecum raucis, tua dum vestigia lustro,
sole
sub ardenti resonant arbusta cicadis.
Ora
anche le greggi cercano ombre e frescura, ora anche i roveti nascondono
le verdi lucertole, e Testili pesta aglio e serpillo, erbe odorose, ai
mietitori stanchi per la violenta calura. Ma con me, mentre seguo le
tue tracce, sotto il sole ardente gli arbusti echeggiano il canto delle
roche cicale.
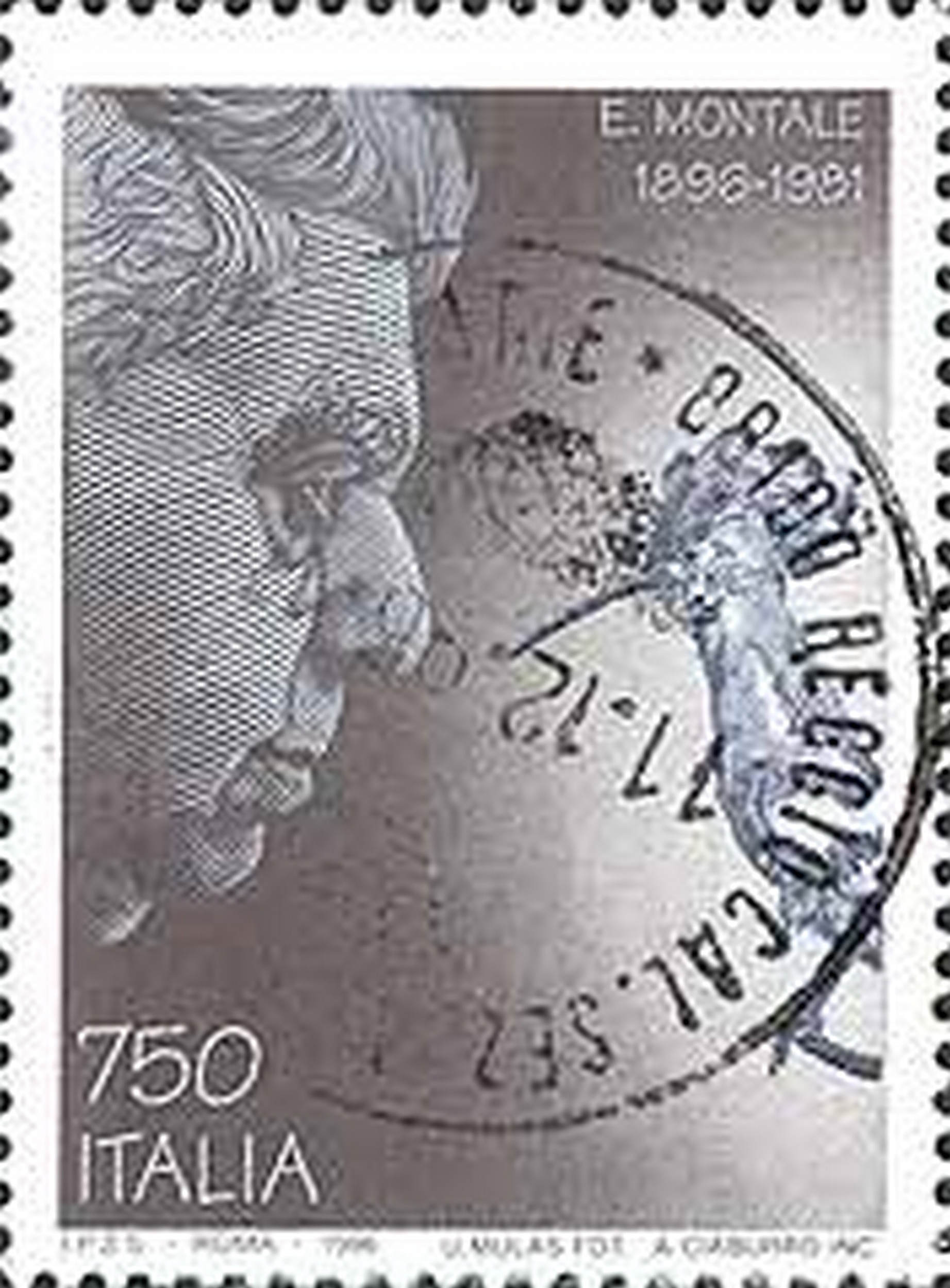 e) Ritroviamo l’elemento topico nella seguente poesia di
Montale, in cui contribuisce insieme con pochi altri elementi (il muro
rovente, il sole che abbaglia) a creare l’ambito dove si colloca la
solitaria contemplazione del poeta, diviso fra la ristrettezza dell’al
di qua (il muro sbarrato) e le improvvise rivelazioni dell’oltre (la
scaglie di mare): e) Ritroviamo l’elemento topico nella seguente poesia di
Montale, in cui contribuisce insieme con pochi altri elementi (il muro
rovente, il sole che abbaglia) a creare l’ambito dove si colloca la
solitaria contemplazione del poeta, diviso fra la ristrettezza dell’al
di qua (il muro sbarrato) e le improvvise rivelazioni dell’oltre (la
scaglie di mare):
Meriggiare
pallido e assorto
presso
un rovente muro d’orto,
ascoltare
tra i pruni e gli sterpi
schiocchi
di merli, frusci di serpi.
Nelle
crepe del suolo o su la veccia
spiar
le file di rosse formiche
ch’ora
si rompono ed ora s’intrecciano
a
sommo di minuscole biche.
Osservare
tra frondi il palpitare
lontano
di scaglie di mare
mentre
si levano tremuli scricchi
di
cicale dai calvi picchi.
E
andando nel sole che abbaglia
sentire
con triste meraviglia
com’è
tutta la vita e il suo travaglio
in
questo seguitare una muraglia
che
ha in cima cocci aguzzi di
bottiglia
(Ossi di seppia)
ascolta questa poesia dalla voce di Montale
f) Così diffuso
è l’elemento topico che da solo può identificare l’estate: expectate
cicadas dice Giovenale (IX, 69) nel senso di attendete l’estate.
g) Per Quasimodo,
nella breve lirica intitolata Estate, le cicale sono il segno
fondamentale della stagione, con le loro caratteristiche (il sole, le
foglie). Ma qui abbiamo anche l’immedesimazione del poeta con le
cicale, secondo una tendenza a condividere con la natura il cambio di
stagioni che si incontra anche in altre poesie (ad esempio Specchio,
qui riportata nella
sezione dedicata alla primavera)
Cicale, sorelle, nel sole
con voi mi nascondo
nel folto dei pioppi
e aspetto le stelle.
Torna all'inizio del documento
2. Il canto
Da elemento topico la cicala diviene simbolo: del canto e
della poesia. Il testo fondamentale in Platone, nello stesso Fedro già
citato, con uno dei miti sull’origine delle cicale:
a) Platone, Fedro, 258-59ù
ΣΩ. Σχολὴ μὲν δή, ὡς ἔοικε· καὶ ἅμα μοι δοκοῦσιν ὡς ἐν τῷ
πνίγει ὑπὲρ κεφαλῆς ἡμῶν οἱ τέττιγες ᾄδοντες καὶ ἀλλήλοις διαλεγόμενοι
καθορᾶν καὶ ἡμᾶς. εἰ οὖν ἴδοιεν καὶ νὼ καθάπερ τοὺς πολλοὺς ἐν
μεσημβρίᾳ μὴ διαλεγομένους ἀλλὰ νυστάζοντας καὶ κηλουμένους ὑφ' αὑτῶν
δι' ἀργίαν τῆς διανοίας, δικαίως ἂν καταγελῷεν, ἡγούμενοι ἀνδράποδ'
ἄττα σφίσιν ἐλθόντα εἰς τὸ καταγώγιον ὥσπερ προβάτια μεσημβριάζοντα
περὶ τὴν κρήνην εὕδειν· ἐὰν δὲ ὁρῶσι διαλεγομένους καὶ παραπλέοντάς
σφας ὥσπερ Σειρῆνας ἀκηλήτους, ὃ γέρας παρὰ θεῶν ἔχουσιν ἀνθρώποις
διδόναι, τάχ' ἂν δοῖεν ἀγασθέντες.
ΦΑΙ. Ἔχουσι δὲ δὴ τί τοῦτο; ἀνήκοος γάρ, ὡς ἔοικε, τυγχάνω ὤν.
ΣΩ. Οὐ μὲν δὴ πρέπει γε φιλόμουσον ἄνδρα τῶν τοιούτων ἀνήκοον εἶᾥναι.
λέγεται δ' ὥς ποτ' ἦσαν οὗτοι ἄνθρωποι τῶν πρὶν Μούσας γεγονέναι,
γενομένων δὲ Μουσῶν καὶ φανείσης ᾠδῆς οὕτως ἄρα τινὲς τῶν τότε
ἐξεπλάγησαν ὑφ' ἡδονῆς, ὥστε ᾄδοντες ἠμέλησαν σίτων τε καὶ ποτῶν, καὶ
ἔλαθον τελευτήσαντες αὑτούς· ἐξ ὧν τὸ τεττίγων γένος μετ' ἐκεῖνο
φύεται, γέρας τοῦτο παρὰ Μουσῶν λαβόν, μηδὲν τροφῆς δεῖσθαι γενόμενον,
ἀλλ' ἄσιτόν τε καὶ ἄποτον εὐθὺς ᾄδειν, ἕως ἂν τελευτήσῃ, καὶ μετὰ ταῦτα
ἐλθὸν παρὰ Μούσας ἀπαγγέλλειν τίς τίνα αὐτῶν τιμᾷ τῶν ἐνθάδε.
Socrate: Abbiamo tempo libero, mi
pare. E mi sembra che nell’afa le cicale cantando e dialogando fra loro
sulle nostre teste guardino anche noi. Se dunque vedessero che anche
noi, come fanno i più sul mezzogiorno, non dialoghiamo ma sonnecchiamo
e per pigrizia mentale ci facciamo affascinare da loro, giustamente
riderebbero, ritenendo che degli schiavi siano venuti in questo rifugio
a dormire, come greggi sul mezzogiorno presso una fonte; qualora invece
vedano che dialoghiamo e le oltrepassiamo navigando, come davanti alle
Sirene, senza farci affascinare, compiacendosi ci darebbero il dono che
hanno l’incarico di dare agli uomini da parte degli dèi.
Fedro: Qual è questo dono che
hanno? Non mi sembra di averne mai sentito parlare.
Socrate: Non è conveniente che un
uomo amante delle Muse non abbia mai sentito tali cose. Si dice che un
tempo queste fossero uomini, di quelli vissuti prima della nascita
delle Muse; e quando nacquero le Muse e si manifestò il canto, alcuni
degli uomini di allora furono così colpiti dal piacere che cantando
trascurarono cibo e bevanda, e morirono senza accorgersene. Da loro in
seguito sorge la stirpe delle cicale, che ottenne dalle Muse il dono di
non aver bisogno fin dalla nascita di nutrimento, ma di cantare subito
senza cibo né bevanda, sino alla fine. E poi si recano dalle Muse e
riferiscono chi fra gli uomini di quaggiù onora ciascuna di loro.
b) L’idea che le cicale non avessero bisogno di cibo, ma al
più si nutrissero di rugiada, diviene presto proverbiale: così in
questo passo di Virgilio:
Ecl. V, 76 segg:
Dum iuga
montis aper, fluvios dum piscis amabit,
dumque thymo
pascentur apes, dum rore cicadae,
semper honos
nomenque tuum laudesque manebunt
Finché il cinghiale amerà i gioghi del
monte e il pesce i fiumi, finché le api si nutriranno di timo e le
cicale di rugiada, sempre resteranno il tuo onore, il tuo nome e la tua
gloria.
c) Il canto delle cicale suggerisce al Carducci una gioiosa
riflessione sulla sua condizione di poeta:
Da: Le “risorse” di San Miniato al
Tedesco, I
Prima una, due, tre, quattro, da altrettanti
alberi; poi dieci, venti, cento, mille, non si sa di dove, pazze di
sole, come le sentì il greco poeta; poi tutto un gran coro che aumenta
d’intonazione e d’intensità co’l calore e co’l luglio, e canta, canta,
canta, su’ capi, d’attorno, a’ piedi de’ mietitori. Finisce la
mietitura, ma non il coro. Nelle fiere solitudini del solleone, pare
che tutta la pianura canti, e tutti i monti cantino, e tutti i boschi
cantino: pare che essa la terra dalla perenne gioventù del suo seno
espanda in un inno immenso il giubilo de’ suoi sempre nuovi amori co’l
sole. A me in quel nirvana di splendori e di suoni avviene e piace di
annegare la conscienza di uomo, e confondermi alla gioia della mia
madre Terra: mi pare che tutte le mie fibre e tutti i miei sensi
fremano, esultino, cantino in amoroso tumulto, come altrettante cicale.
Non è vero che io sia serbato ai freddi silenzi del sepolcro! io vivrò
e canterò, atomo e parte della mia madre immortale.
d) Un’identificazione con la cicala anche nella lirica Cigarra! (in
Libro de Poemas) del poeta spagnolo Federico García
Lorca.
Lorca
considera felice la cicala che, a differenza degli uomini,
non muore curva sulla terra, ma cantando e avvolta dalla
luce:
|
Mas tù, cigarra
encantada,
demarrando
son, te
mueres
y quedas
transfigurada
en sonido y
luz
celeste.
|
Ma tu, cicala incantata,
prodigando suono muori
e resti trasfigurata
in suono e luce celeste.
|
e)
Una canzone dell’argentina Maria
Elena Walsh, composta nel 1973, è divenuta simbolo della
sopravvivenza ad ogni dittatura. Anche qui ricorre il tema della morte
che risale alla lunga al Fedro platonico ma che
rispetto a Lorca si risolve nella possibilità di rivivere e
ricominciare a cantare..
| Como la cigarra |
Come
la cicala |
Tantas veces me
mataron,
tantas veces me morí,
sin embargo estoy aquí
resucitando.
Gracias doy a la desgracia
y a la mano con puñal
porque me mató tan mal,
y seguí cantando. |
Tante volte mi hanno
uccisa,
tante volte sono morta,
eppure sono qui
resuscitata.
Ringrazio la disgrazia
e la mano col pugnale
perché mi uccise così male
e ho continuato a cantare.
|
Cantando al sol
como la cigarra
después de un año bajo la tierra,
igual que sobreviviente
que vuelve de la guerra.
|
Cantare al sole come la
cicala
dopo un anno sotto la
terra,
come un sopravvissuto
che torna dalla guerra.
|
Tantas veces me
borraron,
tantas desaparecí,
a mi propio entierro fuí
sola y llorando.
Hice un nudo en el pañuelo
pero me olvidé después
que no era la única vez,
y volví cantando.
|
Tante volte mi hanno
cancellata,
tante sono scomparsa,
sono stata al mio funerale
sola e piangente.
Ho fatto un nodo al
fazzoletto
però poi mi sono
dimenticata
che non era l’unica volta
e sono tornata a cantare.
|
Cantando al sol
como la cigarra
después de un año bajo la tierra,
igual que sobreviviente
que vuelve de la guerra.
|
Cantare al sole come la
cicala
dopo un anno sotto la
terra,
come un sopravvissuto
che torna dalla guerra.
|
Tantas veces te mataron,
tantas resucitarás,
tantas noches pasarás
desesperando.
A la hora del naufragio
y la de la oscuridad
alguien te rescatará
para ir cantando. |
Tante volte ti hanno
ucciso,
tante resusciterai,
tante notti passerai
disperando.
All’ora del naufragio
e dell’oscurità
qualcuno ti libererà
perché tu vada a cantare.
|
Cantando al sol
como la cigarra
después de un año bajo la tierra,
igual que sobreviviente
que vuelve de la guerra. |
Cantare al sole come la
cicala
dopo un anno sotto la
terra,
come un sopravvissuto
che torna dalla guerra.
|
 clicca qui per
sentire la canzone clicca qui per
sentire la canzone
Torna all'inizio del documento
3. Otium e negotium: la rilettura
moralistica
E’
significativo che il simbolismo cicala/poeta abbia un risvolto
negativo: l’idea cioé che la cicala/poeta non lavora, non produce,
quindi è inutile a sé e agli altri. In questo contesto moralistico,
anche la concezione della cicala che si nutre di rugiada, o non si
nutre del tutto perché vive del suo canto, si modifica: la cicala non
ha di che nutrirsi appunto perché non fa un lavoro produttivo.
L’antagonista, l’animale che lavora per sé e la collettività, è la
formica.
a)
In Esopo troviamo due varianti della stessa favola:
μύρμηξ καὶ τέττιξ
ψῦχος ἦν καὶ χειμὼν κατ' Ὀλύμπου. μύρμηξ δὲ πολλὰς συνάξας ἐν ἀμητῷ ἐν
ἰδίοις οἴκοις ἀπέθηκε. τέττιξ δὲ ἐπὶ τρώγλης ἐνδύνας ἐξέπνει τῇ πείνῃ
λιμῷ κατεχόμενος καὶ ψύχει πολλῷ· ἐδεῖτο οὖν τοῦ μύρμηκος τροφῆς
μεταδοῦναι, ὅπως καὶ αὐτὸς πυροῦ τινος γευσάμενος σωθείη. ὁ δὲ μύρμηξ
πρὸς αὐτόν· "ποῦ, φησίν, ἦς τῷ θέρει; πῶς οὐ συνῆξας τροφὰς ἐν ἀμητῷ;"
καὶ ὁ τέττιξ φησί· "ᾖδον καὶ ἔτερπον τοὺς ὁδοιποροῦντας." ὁ δὲ μύρμηξ
γέλωτα πολὺν <αὐτῷ> καταχέας ἔφη· "οὐκοῦν χειμῶνος ὀρχοῦ."
διδάσκει ἡμᾶς ὁ μῦθος, ὅτι οὐδὲν κρεῖττον τοῦ φροντίζειν τῶν ἀναγκαίων
τροφῶν καὶ μὴ ἀπασχολεῖσθαι εἰς τέρψιν καὶ κωμασίαν. (114)
χειμῶνος
ὥρᾳ τῶν σίτων βραχέντων οἱ μύρμηκες ἔψυχον. τέττιξ δὲ λιμώττων ᾔτει
αὐτοὺς τροφήν. οἱ δὲ μύρμηκες εἶπον αὐτῷ· "διὰ τί τὸ θέρος οὐ συνῆγες
τροφήν;" ὁ δὲ εἶπεν· "οὐκ ἐσχόλαζον ἀλλ' ᾖδον μουσικῶς." οἱ δὲ
γελάσαντες εἶπον· "ἀλλ' εἰ θέρους ὥραις ηὔλεις, χειμῶνος ὀρχοῦ."
ὁ μῦθος δηλοῖ, ὅτι οὐ δεῖ τινα ἀμελεῖν ἐν παντὶ πράγματι, ἵνα μὴ λυπηθῇ
καὶ κινδυνεύσῃ. (114 b)
La formica e la cicala
Era freddo e inverno giù dall’Olimpo. La formica avendo
raccolto molto al tempo della mietitura l’aveva riposto nella sua casa.
La cicala nascostasi in una cavità stava per morire per la fame,
stretta dalla penuria di cibo, e per il gran freddo. Pregò dunque la
formica di prestarle un po’ di cibo, in modo che anch’essa si salvasse
assaggiando qualche po’ di grano. Ma la formica le dice: “Dov’eri in
estate? come mai non hai raccolto del cibo al tempo della mietitura?”
La cicala dice: “Cantavo e rallegravo i viandanti”. E la formica
deridendola molto disse: “Dunque d’inverno balla”.
La favola ci insegna che niente è più importante che
preoccuparsi del cibo necessario e non perder tempo in allegria e
feste. (114)
Nella
stagione invernale, essendosi bagnato il grano, le formiche avevano
freddo.
La cicala
affamata chiese loro del cibo. Ma le formiche le dissero: “Perché in
estate non hai raccolto il cibo?” E quella disse: “Non avevo tempo, ma
cantavo artisticamente”.
E quelle
ridendo dissero: “Se d’estate suonavi, d’inverno balla”.
La favola
mostra che non bisogna essere negligenti in ogni cosa, per non soffrire
e non correre rischi. (114 b)
La favolistica
successiva riprende più volte il tema, o rilevando semplicemente la
differenza fra i due comportamenti o riportando il dialogo col gioco di
parole cantare ~ ballare. Ricordiamo ad esempio la favola 1 del retore
Aftonio, la favola 2 di Teofilatto Simocatta, la favola 43 di Sintipa,
la favola 1 dell’anonimo Brancatianus, tutte comprese nel corpus
Aesopicum.
b) Ritroviamo il
topos nel favolista francese del Seicento La Fontaine:
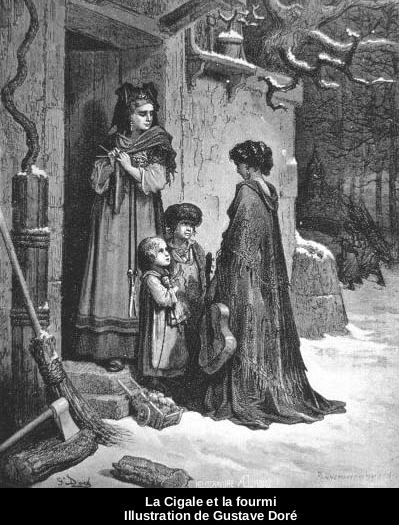
|
La cigale et la
fourmi
|
La cicala e la formica
|
|
La
cigale, ayant chanté
tout l’été,
se trouva fort dépourvue
quand la bise fut venue:
pas un seul petit morceau
de mouche ou de vermisseau:
elle alla crier famine
chez la fourmi sa voisine,
la priant de lui prêter
quelche grain pour subsister
jusqu’à la saison nouvelle:
«Je vous paierai, lui dit-elle,
avant l’août, foi d’animal
interêt et
principal»
La fourmi n’est pas prêteuse:
c’est là son moindre défaut;
«Que faisiez-vous au temps chaud?,
dit-elle à cette
emprunteuse.
«Nuit et jour à tout venant
je chantais, ne vous déplaise».
«Vous chantiez! j’en suis fort aise.
Eh bien! dansez maintenant».
(Livre I, fable 1)
|
La
cicala, avendo cantato
tutta l’estate,
si
trovò molto sprovvista
quando
venne il freddo:
neanche
un solo pezzettino
di
mosca o di vermicello:
andò
a lamentare la carestia
alla
sua vicina formica
pregandola
di prestarle
qualche
granello per sopravvivere
fino
alla nuova stagione:
«Vi pagherò, le disse,
entro
agosto, parola d’animale,
il
capitale e l’interesse»
La
formica non è prodiga:
è il
suo minimo difetto;
«Che facevate nella stagione calda?,
disse a quella accattona.
«Notte e giorno continuamente
cantavo, se non vi spiace »
«Cantavate!
Ne sono molto lieta.
Ebbene! ballate adesso».
Vai
alla traduzione poetica di Emilio de Marchi
|

c) Ma con La
Fontaine la variante moralistica sembra fermarsi. Nella sua opera
pedagogica Émile Rousseau contesta il valore educativo
della favola, che fornisce “una lezione di crudeltà” (Vol. I, libro
II). Su un altro versante la contesta l’entomologo H. Fabre
(1823-1915), che analizzando le abitudini degli insetti arriva a
capovolgere il rapporto fra i due e insieme a fornire una base
scientifica alla concezione classica della cicala “che non mangia e non
beve”:
In luglio,
nelle ore afose del pomeriggio, quando il popolo degli insetti,
estenuato dalla sete, erra cercando invano di abbeverarsi sui fiori
appassiti, secchi, la cicala se la ride della penuria generale. Col suo
rostro, fine succhiello, buca una parte della sua cantina inesauribile.
Stabilitasi sempre cantando su un ramoscello d’arbusto, fora la scorza
ferma e liscia che una linfa maturata dal sole gonfia... Numerosi
assetati la spiano, in effetti; scoprono il pozzo... I più piccoli, per
avvicinarsi alla sorgente, s’insinuano sotto il ventre della cicala
che, gentile, si rizza sulle zampe e lascia via libera agli
importuni... Le più ostinate sono le formiche.
(Souvenirs entomologiques).
Bisogna supporre
che il poeta romano Trilussa (1871-1950) conoscesse il passo
di Fabre, perché una delle poesie dedicate al tema ricalca proprio
questo testo, con l’aggiunta della satira politica:
La cecala
e le formiche
Tutta
l’estate la Cecala canta;
ma, quanno
sente che je viè l’arsura,
lassa perde
la musica e procura
de fa’ un
succhiello ar ramo d’una pianta:
e sbucia e
scava e trapana e lavora
finché nun
vede l’acqua ch’esce fòra.
Ma c’è però
chi aspetta er bon momento
pe’ sfruttà
tante povere fatiche:
e so’
precisamente le Formiche
che vanno a
pizzicalla a tradimento
finché la
bestia, mezza stramortita,
se stacca,
casca e perde la partita.
Allora c’è
l’assarto. Detto fatto
le Formiche
cominceno er via-vai:
ma ne la
furia c’è chi beve assai,
chi beve poco
e chi nun beve affatto.
Nun ce se
bada più: chi ariva ariva,
come a la
Società Coperativa.
(Le storie)
Più accentuata
la satira politico/sociale in queste due poesie dello stesso
autore:
La cecala d’oggi
Una Cecala,
che pijava er fresco
all’ombra der
grispigno e de l’ortica,
pe’ da’ la
cojonella a ‘na Formica
cantò ‘sto
ritornello romanesco:
─ Fiore di pane,
io me la
godo, canto e sto benone,
e invece tu
fatichi come un cane,
─ Eh! da qui
ar bel vedé ce corre poco:
─ rispose la
Formica ─
nun t’hai da
crede mica
ch’er sole
scotti sempre come er foco!
Amomenti
verrà la tramontana:
commare,
stacce attenta... ─
Quanno venne
l’inverno
la Formica se
chiuse ne la tana;
ma, ner sentì
che la Cecala amica
seguitava a
cantà tutta contenta,
uscì fòra e
je disse: ─ Ancora canto?
ancora nun la
pianti?
─ Io? ─ fece
la Cecala ─ manco a dillo:
quer che
facevo prima faccio adessi;
Mò ciò
l’amante: me mantiè quer Grillo
che 'sto
giugno me stava sempre appresso.
Che dichi?
l’onestà? Quanto sei cicia!
M’aricordo
mi’ nonna che diceva:
Chi lavora
cià appena una camicia,
e sai chi ce
n’ha due? Chi se la leva.
(Le favole)
La cecala rivoluzzionaria
Una cecala
rivoluzzionaria
diceva a la
Formica:
─ Povera
proletaria!
Schiatti da
la fatica
senza pensà
che un giorno finirai
sott’a zampe
de la borghesia
che a le
formiche nun ce guarda mai!
Ma che lavori
a fa’, compagna mia?
Pianta er
padrone e sciopera
prima
ch’arivi un piede propotente
che te voja
fregà la mano d’opera!
Tu guarda a
me: d’inverno nun fo gnente,
e ammalappena
sento li calori
me sdrajo in
faccia ar sole e canto l’Inno
de li
Lavoratori!
(ibid.)
Nel ventesimo
secolo la contestazione del topos moralistico assume le forme
più varie e più popolari. Una storia a fumetti disneyana degli anni ’50
introduce una sorta di compromesso: la cicala non viene respinta dal
popolo delle formiche, ma viene ospitata e invitata a suonare per
rallegrare le formiche durante il lungo inverno; tuttavia quello che
sembrerebbe uno scambio equo e il riconoscimento dei diversi compiti ha
una conclusione che riprende l’antica morale: la cicala canta “in fa”,
esaltando la necessità del lavoro.
Il
fumetto (che in realtà riprende un cartone animato del 1934, inserito
nelle Si
 lly Symphonies) parla di una
cavalletta, e il disegno sembra riprodurre più il tipo della cavalletta
che quello della cicala (qui accanto, la copertina del 45 giri
commercializzato nel 1962, che conteneva la canzone del cartone
animato, con la voce di Pinto Colvig). Presumibilmente dobbiamo
risalire ad un equivoco lessicale. L’inglese non possiede un
termine per “cicala”: i dizionari riportano per lo più solo cicada (con
plurale cicadas o cicadae), un latinismo di uso
scientifico; quando riportano un altro termine, questo è grasshopper,
parola dall’evidente etimologia (“che balza nell’erba”) e che indica
(cercandola dall’inglese) diversi altri tipi di insetti, fra cui il
grillo e soprattutto la cavalletta. E’ probabile che il creatore
americano della storia disneyana sia partito dalla traduzione inglese
di una favola in cui era usata la parola grasshopper e abbia
frainteso; il traduttore italiano si è adeguato soprattutto al disegno.
Ma non c’è dubbio che all’origine vi sia una rilettura del topos
tradizionale. lly Symphonies) parla di una
cavalletta, e il disegno sembra riprodurre più il tipo della cavalletta
che quello della cicala (qui accanto, la copertina del 45 giri
commercializzato nel 1962, che conteneva la canzone del cartone
animato, con la voce di Pinto Colvig). Presumibilmente dobbiamo
risalire ad un equivoco lessicale. L’inglese non possiede un
termine per “cicala”: i dizionari riportano per lo più solo cicada (con
plurale cicadas o cicadae), un latinismo di uso
scientifico; quando riportano un altro termine, questo è grasshopper,
parola dall’evidente etimologia (“che balza nell’erba”) e che indica
(cercandola dall’inglese) diversi altri tipi di insetti, fra cui il
grillo e soprattutto la cavalletta. E’ probabile che il creatore
americano della storia disneyana sia partito dalla traduzione inglese
di una favola in cui era usata la parola grasshopper e abbia
frainteso; il traduttore italiano si è adeguato soprattutto al disegno.
Ma non c’è dubbio che all’origine vi sia una rilettura del topos
tradizionale.
Il cartone animato del 1934 è
accessibile su YouTube:  clicca
qui per vederlo. clicca
qui per vederlo.
In modo più netto Rodari rivendica la gratuità della poesia in
una delle sue favolette:
Chiedo scusa alla favola
antica
se non amo l’avara formica.
Io sto dalla parte della cicala
che il più bel canto non vende, regala.
Stranamente è proprio il compito che la cicala
si era assunta nella favola esopica: rallegrare col suo canto
gratuitamente i viandanti; ma in Esopo un moralismo piuttosto gretto
aveva eliminato come improduttivo questo compito.
Una canzoncina che faceva da sigla allo show
televisivo Fantastico 1981, cantata e ballata da Heather
Parisi, contestava scherzosamente il topos favolistico,
ricorrendo a un gioco di parole che temiamo non sia stato capito da
molti:
Cicale
Delle cicale
ci cale, ci
cale, ci cale,
della formica
invece non ci
cale mica...
(di Testa, Miseria, De Vita,
Testi, Ricci, ed. Sugar Music Peer).
Per accedere a un video della canzone clicca a uno dei
seguenti indirizzi:
https://www.dailymotion.com/video/x3q2kr2
http://it.youtube.com/watch?v=sAqqpWmt2EU&feature=related
Ultimamente si è aggiunta anche la voce del
premio Nobel 1993, la scrittrice americana Toni Morrison,
autrice di un libro intitolato “Chi
ha più coraggio? La formica o la cicala?” (ed. it. Frassinelli). In
un'intervista spiega: “La formica sarà stata anche brava a fare le
provviste per l’inverno, ma è stato il canto della cicala a
incoraggiarla nel suo lavoro. Noi artisti, insomma, non siamo così
inutili”
4. La vecchiaia
 Fra le varianti del mito di Eos (Aurora) e Titono ve n’è
una che termina nella metamorfosi in cicala. Il mito nella sua storia
di base è già presente nell’Inno omerico ad
Afrodite: Fra le varianti del mito di Eos (Aurora) e Titono ve n’è
una che termina nella metamorfosi in cicala. Il mito nella sua storia
di base è già presente nell’Inno omerico ad
Afrodite:
ὣς δ'
αὖ Τιθωνὸν χρυσόθρονος ἥρπασεν Ἠὼς
ὑμετέρης
γενεῆς ἐπιείκελον ἀθανάτοισι.
βῆ
δ' ἴμεν αἰτήσουσα κελαινεφέα Κρονίωνα
ἀθάνατόν
τ' εἶναι καὶ ζώειν ἤματα πάντα·
τῇ
δὲ Ζεὺς ἐπένευσε καὶ ἐκρήηνεν ἐέλδωρ.
νηπίη,
οὐδ' ἐνόησε μετὰ φρεσὶ πότνια Ἠὼς
ἥβην
αἰτῆσαι, ξῦσαί τ' ἄπο γῆρας ὀλοιόν.
τὸν
δ' ἦ τοι εἵως μὲν ἔχεν πολυήρατος ἥβη,
Ἠοῖ
τερπόμενος χρυσοθρόνῳ ἠριγενείῃ
ναῖε
παρ' Ὠκεανοῖο ῥοῇς ἐπὶ πείρασι γαίης·
αὐτὰρ
ἐπεὶ πρῶται πολιαὶ κατέχυντο ἔθειραι
καλῆς
ἐκ κεφαλῆς εὐηγενέος τε γενείου,
τοῦ
δ' ἦ τοι εὐνῆς μὲν ἀπείχετο πότνια Ἠώς,
αὐτὸν
δ' αὖτ' ἀτίταλλεν ἐνὶ μεγάροισιν ἔχουσα
σίτῳ
τ' ἀμβροσίῃ τε καὶ εἵματα καλὰ διδοῦσα.
ἀλλ'
ὅτε δὴ πάμπαν στυγερὸν κατὰ γῆρας ἔπειγεν
οὐδέ
τι κινῆσαι μελέων δύνατ' οὐδ' ἀναεῖραι,
ἥδε
δέ οἱ κατὰ θυμὸν ἀρίστη φαίνετο βουλή ·
ἐν
θαλάμῳ κατέθηκε, θύρας δ' ἐπέθηκε φαεινάς.
τοῦ
δ' ἦ τοι φωνὴ ῥεῖ ἄσπετος, οὐδέ τι κῖκυς
ἔσθ'
οἵη πάρος ἔσκεν ἐνὶ γναμπτοῖσι μέλεσσιν. (vv. 218-238)
Così Aurora dal trono d’oro rapì a sua
volta Titono, simile agli immortali della vostra stirpe. Andò poi a
chiedere al Cronide adunatore di nembi che fosse immortale e vivesse
per sempre: e Zeus annuì e le esaudì il desiderio. Sciocca, non venne
in mente alla venerabile Aurora di chiedere la giovinezza e di
allontanare l’odiosa vecchiaia. Così finché egli godette dell’amabile
giovinezza, abitò presso le correnti dell’Oceano ai confini della
terra, rallegrandosi insieme ad Aurora mattutina, dal trono d’oro; ma
quando dalla bella testa e dal nobile mento si diffusero i primi crini
bianchi, la venerabile Aurora lo cacciò dal suo letto, curandolo però
nella casa, con cibo e ambrosia e belle vesti. Quando poi lo prese del
tutto l’orribile vecchiaia e non poteva più muovere né alzare le
membra, le venne nell’animo questo ottimo progetto: lo chiuse nel
talamo, e serrò le splendide porte. La voce di lui corre incessante, ma
non c’è più la forza che prima era nelle agili membra.
Ma una
conclusione diversa troviamo ad esempio in:
a) Schol
Hom. ad Il. XI, 1:
Ἱερώνυμος (fr.
15 We.) φησὶ τὸν Τιθωνὸν αἰτήσασθαι ἀθανασίαν παρὰ τῆς Ἠοῦς, οὐ μέντοι
καὶ ἀγηρασίαν· ὡς δώὲ πολλῷ τῷ γήρᾳ χρώμενος ἐδυσφόρει, αἰτήσασθαι
θάνατον· ἡ δὲ ἀδυνατοῦσα εἰς τέττιγα αὐτὸν μεταβάλλει, ὅπως ἥδοιτο
διηνεκῶς τῆς φωνῆς αὐτοῦ ἀκούουσα.
Gerolamo (fr. 15 We.) dice che Titono chiese
l’immortalità ad Aurora, ma non l’assenza di vecchiaia; quando poi
oppresso pesantemente dalla vecchiaia era in tristi condizioni chiese
la morte; ma lei non avendone la possibilità lo trasforma in cicala,
per gioire sentendo continuamente la sua voce.
Quella che nell’Inno
appariva una scelta crudele (anche se qualificata come ottima
dall’autore) in questa variante diviene segno di affetto: la
conservazione della voce dell’amato. Nell’Inno Titono continua a
cianciare da solo, oltre le porte chiuse; qui perde la sua immagine
ormai triste, ma la voce continua a rallegrare la sua antica compagna.
 b) Se questa è la raffigurazione mitica dell’analogia
vecchiaia-cicala, il tertium comparationis era già in Omero:
implicitamente l’inutilità della cicala e del vecchio rispetto alla
vita attiva, esplicitamente l’abilità di parlare/cantare. Risale ad
Omero, dunque, l’alternativa attività/parola, senza che vi sia una
negatività per il secondo elemento: negotium ed otium
hanno ciascuno il suo posto. b) Se questa è la raffigurazione mitica dell’analogia
vecchiaia-cicala, il tertium comparationis era già in Omero:
implicitamente l’inutilità della cicala e del vecchio rispetto alla
vita attiva, esplicitamente l’abilità di parlare/cantare. Risale ad
Omero, dunque, l’alternativa attività/parola, senza che vi sia una
negatività per il secondo elemento: negotium ed otium
hanno ciascuno il suo posto.
Iliade, III, vv.149 segg.:
ἥατο
δημογέροντες ἐπὶ Σκαιῇσι πύλῃσι,
γήραι δὴ πολέμοιο πεπαυμένοι, ἀλλ' ἀγορηταὶ
ἐσθλοί, τεττίγεσσιν ἐοικότες οἵ τε καθ' ὕλην
δενδρέῳ ἐφεζόμενοι ὄπα λειριόεσσαν ἱεῖσι
Sedevano gli
anziani al di sopra delle porte Scee, esclusi dalla guerra per la
vecchiaia, ma abili parlatori, simili alle cicale che nel bosco,
appollaiate su un albero, emettono una voce dolce come un giglio.
c) Nel prologo
degli Aitia Callimaco opera una sintesi fra i due simbolismi
della cicala, facendo un doppio paragone con se stesso: poeta e anziano:
fr. 1 Pf.
ἐνὶ τοῖς γὰρ ἀείδομεν οἳ λιγὺν ἦχον
τέττιγος, θ]όρυβον δ' οὐκ ἐφίλησαν ὄνων.
θηρὶ μὲν οὐατόεντι πανείκελον ὀγκήσαιτο
ἄλλος, ἐγ]ὼ δ' εἴην οὑλ[α]χύς, ὁ πτερόεις,
ἆ πάντως, ἵνα γῆρας ἵνα δρόσον ἣν μὲν ἀείδω
πρώκιον ἐκ δίης ἠέρος εἶᾥδαρ ἔδων,
αὖθι τὸ δ' ἐκδύοιμι, τό μοι βάρος ὅσσον ἔπεστι
τριγλώχιν ὀλοῷ νῆσος ἐπ' Ἐγκελάδῳ.
Μοῦσαι γὰρ ὅσους ἴδον ὄθματι παῖδας
μὴ λοξῷ, πολιοὺς οὐκ ἀπέθεντο φίλους.
Infatti noi cantiamo fra quelli che amano l’echeggiare
melodioso della cicala, non lo schiamazzo degli asini. Un altro si
gonfi come l’orecchiuto animale, ma io sia la lieve, l’alata, ahimè! in
tutto, nella vecchiaia e nella rugiada: io canti nutrendomi di questa
come rorido cibo sceso dall’etere divino, e di quella mi possa
liberare, che pesa su di me quanto l’isola trinacria sull’odioso
Encelado. Infatti quanti le Muse guardarono da piccoli con occhio non
ostile, anche quando sono canuti li hanno cari.
Torna all'inizio del documento
|

![]()
 Cliccando sul bottone hai questa pagina
in formato stampabile o in pdf
Cliccando sul bottone hai questa pagina
in formato stampabile o in pdf