|
L’identità
originaria dei Romani
nei
testi epigrafici più antichi
di
Alfredo Valvo
All’epigrafia
è assegnato il
compito di raccogliere e di studiare le testimonianze cronologicamente
più
risalenti della nostra civiltà. Ad essa è legata la speranza degli
studiosi del
mondo antico di ricostruire la storia più remota cercando le vestigia
del
passato nella loro forma più concreta, rappresentata dalla parola. La
parola
rimane perciò il fondamento del nostro procedere risalendo indietro nel
tempo.
Arnaldo
Momigliano aggiungeva alle
fonti documentarie tradizionali per la ricostruzione storica anche la
storia
delle parole, che tante volte aiuta in modo decisivo la conoscenza
storica,
come è il caso di alcune magistrature romane, ad esempio la pretura (da
prae-ire), oppure il procedimento dell’auctoritas patrum, col quale i patres,
depositari della legittimità del potere e, prima, fondatori della civitas, ‘facevano crescere’, augebant,
le decisioni prese nei concilia plebis
finché alla plebe non furono riconosciuti pari diritti dai
discendenti degli antichi patres, i patricii.
La conoscenza storica non può
prescindere dalla conoscenza dell’evoluzione linguistica e la civiltà
dell’epigrafia, come ebbe a chiamarla il compianto Giancarlo Susini,
che
ricordiamo con rimpianto unanime nel decennale della scomparsa, è
tributaria
delle conoscenze acquisite dalla glottologia in quasi due secoli di
ricerche e
di riflessioni, affidate ai celebri Dizionari etimologici della lingua
greca e
latina e ad opere indispensabili tanto allo storico quanto al
glottologo come Il vocabolario delle istituzioni
indoeuropee
di Emile Benveniste, al quale faremo spesso riferimento.
I
Romani non ci hanno detto molto
finora sulla loro identità originaria. Anzi siamo ben lontani
dall’avere
cognizione sufficiente dei loro inizi. E’ quasi impossibile dare una
collocazione precisa all’origine dei comizi, a cominciare da quelli
curiati,
sebbene anche in questo caso ci sovvenga la storia della parola: curie
da *co-viriae, l’assemblea del popolo
in armi. Essi eleggevano probabilmente il loro capo, come lascia
intuire la lex de imperio, al quale era dato il
nome di rex. Ma già qui ci imbattiamo
in numerosi problemi. Questo nome, che leggiamo con sicurezza in ben
due fra i
documenti epigrafici più antichi (il Cippo del Foro e una grande
ciotola di
bucchero con graffito all’interno, al centro, il nome rex),
entrambi anteriori alla fine del VI secolo o, al massimo,
risalenti al principio del V, compare solo alle due estremità del mondo
indeuropeo e manca nella parte centrale di esso. Il Benveniste richiama
in
proposito il fenomeno della sopravvivenza di termini relativi alla
religione e
al diritto alle due estremità del mondo indeuropeo: nella società
indoiranica e
in quella italoceltica.
Questo fenomeno è riconducibile all’esistenza di potenti collegi di
sacerdoti
depositari delle tradizioni sacre, che essi mantengono in vita con un
rigore
formalistico. In proposito basti ricordare a Roma il collegio dei Fratres Arvales, presso gli Umbri il
collegio dei Fratres Atiedii di Iguvium,
presso i Celti i Druidi; per
l’Oriente i sacerdoti indiani o i Magi iranici, conservatori della
tradizione
zoroastriana. Naturalmente, è dallo stesso tema *reg-
che derivano composti come Vercingeto-rix.
Da
quanto detto a riconoscere
l’originaria funzione sacerdotale del rex
anche a Roma il passo è breve, ed è altrettanto spiegabile, sebbene qui
siamo
costretti a saltare passaggi probabilmente irrinunciabili per i
glottologi, la
permanenza nella tradizione romana, e quindi nell’uso, del termine rex come appunto rex sacrorum, che non
è soltanto ‘ciò che resta’ della funzione
regale ma piuttosto la restituzione alla parola della sua funzione
principale e
originaria. Forse anche il ruolo dell’interrex
in piena età storica – quello di convocare i comizi per eleggere i
consoli suffecti in caso di morte dei consoli
ordinari – attingeva più all’auctoritas
che emanava dalla funzione sacerdotale della regalità che alla
personalità di
chi ne era investito, il quale tuttavia doveva appartenere al
patriziato ed
aver rivestito le magistrature (prassi da riferire alla tradizione
legata ai
comizi curiati, degli uomini in arme).
Tuttavia
il nome rex riserva altre sorprese, almeno per gli
epigrafisti. Il termine regio, il
verbo regere da cui rectus, altri
derivati da questi, tutti
formati sull’originario *reg-,
indicano linee rette tracciate sulla terra o sulla volta del cielo;
quest’ultima operazione è propria degli auguri ed è descritta da Livio
(I 18,7)
in un linguaggio altamente significativo per la sua non affettata
arcaicità e i
riferimenti al costume augurale: [Numa] accitus,
sicut Romulus augurato urbe
condenda regnum adeptus est, de se quoque deos consuli iussit. Inde ab
augure,
cui deinde honoris ergo publicum id perpetuumque sacerdotium fuit,
deductus in
arcem,in lapide ad meridiem versus consedit. … Inde ubi prospectu in
urbem
agrumque capto, deos precatus, regiones
ab oriente ad occasum determinavit, dextras ad meridiem partes, laevas
ad
septentrionem esse dixit; signum contra quo longissime conspectum oculi
ferebant animo finivit; tum lituo in laevam manum translato, dextra in
caput
Numae imposita, ita precatus est: Iuppiter pater, si est fas
hunc Numam Pompilium cuius ego caput teneo regem Romae
esse,
uti [= utinam] tu signa nobis certa
adclarassis inter eos fines quos feci.
Regio rappresenta il punto d’arrivo di una retta
tracciata per
terra o in cielo (in termini augurali templum
in terris, templum in caelo)
che delimita
gli spazi (detti appunto regiones) entro
i quali uomini e dei possono comunicare tra loro attraverso signa,
gli auspici, domandati e interpretati
dagli auguri, la cui funzione sembra essere stata connessa
originariamente con
la elezione del rex. Conferma del
significato originario di regio si
trova nelle espressioni recta regione, recto
rigore (tracciare una linea
retta) di uso quasi esclusivamente agrimensorio. Regere
e quindi rectus
hanno perciò il significato di ‘tracciare una linea retta’, ‘retto,
diritto
come una linea tracciata’, nella sua valenza tecnica e anche morale. La
distinzione degli spazi, indicata anche dall’espressione regere
fines, ‘tracciare confini in linea retta’ è alla base della
convivenza pacifica di uomini e dei sulla terra, dunque della pax deorum. Regio è dunque un limite di
pace, essenziale per la sopravvivenza
umana, deciso d’intesa con gli dei: di qui il carattere di assoluta
sacralità
dei confini terrestri, del confine fra la Città e ciò che sta fuori di
essa, del
limite del sacro e del profano, del territorio di pertinenza della
divinità e
perciò del fas, termine al quale
ricorre Livio, forse già presente nel testo inciso sul Cippo del Foro,
se
stiamo all’integrazione proposta (nella riga 4) dal Goidànich con
riferimento
ai loca, e comunque mai esclusa dalle
letture successive. Il Cippo del Foro, del resto, è nella
interpretazione più
accreditata un lapis finalis tra
sacro e profano e la minaccia di sacer
contenuta in esso è la conseguenza stessa del dominio del fas.
Se
una prima conclusione si può
trarre è certo non secondario in Livio che il primo successore di
Romolo, al
quale si attribuiscono le istituzioni religiose (mentre solo più tardi
il re Hostilius definirà le regole del bellum
iustum), definisca e si faccia
garante del rispetto degli spazi divini (e quindi degli spazi umani)
della Città,
all’origine della quale c’è un patto con gli dei, un fatto
eminentemente
religioso, del quale il rex è
garante, come narrava la tradizione della quale Livio è interprete, che
coincide con quanto è stato conservato dall’epigrafia più antica di
Roma, nella
quale il rex è ricordato in due delle
testimonianze epigrafiche più remote, forse non solo per caso. Per il
Benveniste, «il rex indoeuropeo è
molto più religioso che politico. La sua missione non è di comandare,
ma di
fissare delle regole, di determinare ciò che è, in senso proprio,
‘retto’». Per
Cicerone, la recta ratio è la legge,
grazie alla quale, egli afferma, consociati homines cum dis putandi sumus. Inter quos… communio legis,
inter eos
communio iuris est. Quibus
autem haec sunt inter eos communia, ei
civitatis eiusdem habendi sunt. Il
punto di arrivo di quanto abbiamo detto è la convivenza possibile
fra uomini e dei all’interno della civitas,
fondata sulla legge comune: la legge naturale. La presenza del rex è rivelatrice di tutto questo. Sotto
questo punto di vista sembra accertata la prevalenza della componente
religiosa
del regime monarchico nella Roma delle origini.
Questo
per quanto riguarda il rex.
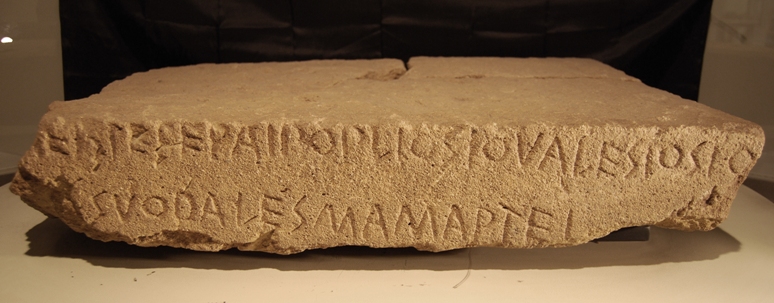
Nel Lapis Satricanus, databile
a poco dopo la metà del VI secolo a.C. (il supporto epigrafico era già
stato
reimpiegato come gradino nel tempio di Mater Matuta almeno una diecina d’anni
prima della fine del secolo VI), quindi in età ancora monarchica, sono
presenti
le due parole socii (con
l’integrazione delle prime tre lettere: ---]iei)
e suodales (seguendo lettura e interpretazione di M.
Guarducci).
L’obbedienza
alle leggi, delle
quali siamo tutti schiavi per essere tutti liberi (Cicerone nella pro Cluentio),
è condizione, fin dagli inizi, perché possa esistere la civitas.
Ancora Cicerone esplicita nel I libro del De re publica
(25, 39), per bocca di
Scipione Emiliano, le condizioni per poter definire il populus:
Est igitur, inquit
Africanus, res publica res populi, populus autem non omnis hominum
coetus
quoquo modo congregatus, sed coetus multitudinis iuris consensu et
utilitatis
communione sociatus. Nel passaggio
alla diarchia assume evidenza il popolo. Esso non è una somma informe
di
persone ma un organismo ben ordinato che si distingue per il consensus iuris, la condivisione delle
norme che regolano la vita comune (ius
indica in origine la conformità a una regola [Benveniste] ed è perciò
un
concetto religioso) e la communio
utilitatis, la condivisione del bene comune. Su questi due
fondamenti è
costruita la societas romana (sociatus).
Con
la parola socius, colta nella medesima accezione di
‘alleato’ in cui la usa Cicerone, e di ‘compagno’, in particolare
‘compagno
d’arme’, per metà integrata ma senza alternative consistenti, si apre
il Lapis Satricanus. L’iscrizione ricorda i
latori del dono o ex-voto a Mater Matuta:
sono i compagni di Publio
Valerio, dei quali si precisa la connotazione anche come suodales
di Marte.
La societas che legava a Publio Valerio i suoi compagni è
una alleanza
stretta sul piano di parità, un rapporto diverso quindi da quello di clientela nel quale la differenza di
forze fra chi domanda, i clientes, e
chi concede la protezione, il patronus,
è costitutiva del vincolo che si instaura. L’alleanza e la clientela
però sono
entrambe fondate sulla fides, che anche
nel nostro caso si rivela il primo vincolo stabile, conosciuto e
testimoniato, posto
a fondamento della società romana.
Il
carattere fortemente
conservativo dei Romani nel campo delle istituzioni tanto di quelle
civili
quanto di quelle religiose, e l’indicazione di societas
precisata dall’altra indicazione suodales permettono
alcune considerazioni. Si può riconoscere nel
vincolo di alleanza fra uomini d’arme un legame già fondato sulla fides, che in senso proprio è il
‘credito’ del quale si gode presso qualcuno ma è anche l’affidabilità
altrui
(ad es., degli dei quando se ne domanda la protezione: pro
divom fidem oppure: di,
obsecro vestram fidem [Benveniste, 87]). Nel caso dei socii
di Publio Valerio prevale la fides reciproca:
la societas
è composta per definizione da uomini liberi nell’aderirvi, essa perciò
è
fondata su una uguaglianza fra coloro che ne fanno parte. Si tratta di
uno
‘scambio’ reciproco di fides. Se ascoltiamo Cicerone (de
off. 3, 31, 111): nullum… vinculum ad
adstringendam fidem iure iurando maiores artius esse voluerunt. Id
indicant
leges in duodecim tabulis etc. Il vincolo di fides
si stringeva solo attraverso il giuramento: è probabile che
anche i compagni di Publio Valerio siano ricorsi a questo antichissimo
vincolo,
più forte di ogni altro, per confermare la fides
reciproca.
La sodalitas, che nel Digesto (47, 12, 4) presuppone
l’appartenenza ad
un collegium (suodales sunt qui eiusdem
collegii sunt quod Graeci ἑταιρίαν vocant), precisa il legame tra i
compagni di Valerio.
Essi oltre al vincolo di fides sono uniti anche dal
comune culto
a Marte, il ferus Mars del Carmen Arvale.
La netta distinzione fra socii e sodales
è importante perché segna la altrettanto netta divisione
fra il legame di societas generato
dalla fides e quello religioso,
manifestamente più forte e solido del primo.
Le parole rex, socii, suodales, che compaiono con certezza nei documenti più
antichi e
che rendono possibile qualche riflessione con più frutto di altre, non
possono
aprire spiragli decisivi per rispondere alla domanda che ci siamo
implicitamente posti all’inizio, se sia possibile riconoscere aspetti
identitari delle origini di Roma, tanto più in un breve e forse un po’
tormentato itinerario come quello seguito fin qui. Rimane comunque
accertato
che nell’identità originaria di Roma sono già presenti le connotazioni
della
società romana pienamente evoluta. Certe nozioni non possono esistere
senza un
loro retroterra né evolversi senza aver in sé i contenuti che
presentano alla
fine della loro evoluzione. Per questo pare di poter concludere che
Roma
presenta caratteristiche ben riconoscibili già nella documentazione
epigrafica
più antica fortunatamente a noi pervenuta.
TESTI
Liv.
I 18,7: [Numa] accitus, sicut Romulus
augurato urbe condenda regnum adeptus
est, de se
quoque deos consuli iussit. Inde ab augure, cui deinde honoris ergo
publicum id
perpetuumque sacerdotium fuit, deductus in arcem,in lapide ad meridiem
versus
consedit. … Inde ubi prospectu in urbem agrumque capto, deos precatus, regiones ab oriente ad occasum
determinavit, dextras ad meridiem partes, laevas ad septentrionem esse
dixit;
signum contra quo longissime conspectum oculi ferebant animo finivit;
tum lituo
in laevam manum translato, dextra in caput Numae imposita, ita precatus
est:
Iuppiter pater, si est fas hunc
Numam Pompilium cuius ego caput teneo regem Romae esse, uti [= utinam] tu signa nobis certa adclarassis
inter eos fines quos feci.
Cic. De leg. I 7,
23: lege
quoque consociati homines cum dis putandi sumus. Inter quos… communio
legis, inter eos communio iuris est. Quibus autem haec sunt inter eos
communia, ei civitatis eiusdem habendi sunt.
Cic. De re publ. I 25, 39: Est igitur, inquit
Africanus, res publica
res populi, populus autem non omnis hominum coetus quoquo modo
congregatus, sed
coetus multitudinis iuris consensu et utilitatis communione sociatus.
Cic. De off.
III 31, 111: nullum…
vinculum ad adstringendam fidem iure
iurando maiores artius esse voluerunt. Id indicant leges in duodecim
tabulis
etc.
|


 Cliccando sul bottone hai
questa pagina in formato stampabile o in pdf
Cliccando sul bottone hai
questa pagina in formato stampabile o in pdf![]()