|
DUE
NOTE DI PIETRO RAPEZZI
1. Nel laboratorio della traduzione
Marziale, V 34: Epicedio
per
Erotio
Un
percorso poetico
2.
Nota alla traduzione delle Odi di Orazio
La prima
volta che sono venuto a contatto con Marziale è
stato nella vecchia scuola media di tanti anni fa, quando
il latino era materia obbligatoria fin dalla prima media. Eravamo in
terza ed avevamo come antologia latina un libriccino semplice e
disadorno (che conservo ancora, un po’ gualcito e con qualche pagina in
meno), ma contenente
una ricca scelta di testi, sia di prosa che di poesia, annotati con
gusto e senso didattico. C’erano solo pochi epigrammi di Marziale, ma
la loro arguzia mi colpì subito e mise in moto la mia tendenza a
rendere
in italiano l’effetto che avevano suscitato in me. Allora erano solo
frammenti ed abbozzi, ma qualche anno dopo, al ginnasio e al liceo
classico, cominciai a dare forma compiuta ai miei tentativi, estesi
anche ad altri
poeti (alcuni di questi figurano su “Zetesis.it”, come La morte di
Priamo, Virgilio, Eneide , II, 526-558 e Sulla
tomba del fratello, Catullo c.101). Allora la mia
cultura letteraria era tutta di tipo classicistico, fondata
principalmente su poeti come Alfieri, Foscolo, Leopardi, Carducci, con
una prima frequentazione di Dante e di Petrarca. Della poesia
novecentesca conoscevo
molto poco e il verso libero non mi convinceva. Per me a quel tempo il
verso della poesia era l’endecasillabo, eventualmente
con qualche settenario. Delle versioni poetiche dai classici conoscevo
in primo luogo quelle da
Omero del Monti e del Pindemonte, i cui poemi si leggevano a scuola
quasi per
intero. Al ginnasio avevamo letto l’Eneide nella versione dell’Albini,
anch’essa in endecasillabi, ma io andavo leggendo per conto mio anche
quella di Annibal Caro e i frammenti di altri traduttori come Alfieri
e Leopardi. Il mio gusto era ovviamente influenzato da questa
formazione e anche il mio vocabolario poetico non si era ancora
completamente liberato da certi arcaismi. Quando mi imbattei nel
tenerissimo epicedio di Marziale,
V 34, per la morte della piccola Erotio, provai una tale emozione, che
mi sentii immediatamente spinto a cercare di restituirne i valori
poetici in italiano. Nacque così la prima versione in terzine rimate di
questo
celebre epigramma (vedi in calce). La pubblicazione avvenne qualche
anno dopo, quando conobbi la rivista didattico-letteraria “Gymnasium”,
diretta da Gian Luigi Zuretti ed edita dalla S.E I.. Era, a giudizio
mio,
una bella traduzione, 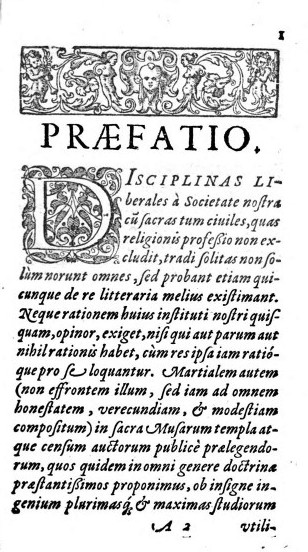 con versi delicati e commossi, ma il suo
stampo
era di tipo arcaizzante e con qualche vocabolo letterario ormai
disusato, come l’ “aere superno”e l’ “adre ombre”, in
cui figurava una chiara reminiscenza del sonetto Funere mersit
acerbo del
Carducci per la morte del figlioletto Dante, vv. 12-13: Oh, giù ne
l’adre/ sedi accoglilo tu, in fine di verso e in enjambement,
come nella mia traduzione. Non
mancava qualche apòcope, anch’essa ormai disusata in
poesia, anche se, devo riconoscere che, in qualche caso, come nei vv.
4-5, il troncamento accresceva col suo
suono cupo la sinistra coloritura timbrica dell’aldilà: perché
l’adre/ ombre non la riempian di paura,/ né
l’orrido trifauce can d’Averno. A quel
tempo ne ero soddisfatto, ma era cominciato intanto il mio processo di
liberazione dagli schemi letterari ottocenteschi e di apertura al
linguaggio vivo del nostro tempo, fino all’insorgere in me
di una tale insofferente reazione, che sentii l’insopprimibile bisogno
di dare una forma del tutto nuova alla versione di quell’epigramma, che
sentivo lontano, per la sua toccante semplicità, dalla mia
troppo elaborata e letteraria trasposizione, non più del tutto in
accordo col mio nuovo gusto poetico. Nacque così, per una estrema
ricerca di semplicità e di essenzialità, la seconda versione,
che apparve nel 1969 nella rivista senese “Ausonia”, diretta dal poeta
e traduttore Luigi Fiorentino (vedi in calce). Rappresentava certamente
uno stacco notevole dalla prima: nessun arcaismo, nessuna movenza
classicheggiante,
una forma sciolta e viva, con accenti teneri e intensi, molto più
vicina all’originale. Felice anche la correzione di “appunto” con
“appena”, che accentua la pietà per la tenera
età della piccola. La versione tuttavia, nata in diretta antitesi con
la prima, non rispondeva ancora in tutto all’originale: c’era ancora
qualcosa da ritoccare. Con la terza ed ultima versione, pubblicata
nel volume ”Marziale, Epigrammi”, 2013
(vedi in calce), si conclude quel lungo percorso poetico di affinamento
e adeguamento, secondo il criterio della fedeltà allo spirito e ai
valori stilistici del testo sempre da me seguito. Nell’ultima
versione ho dunque recuperato sia il nome dei genitori del poeta, sia
quello della piccola Erotio, omesso nella precedente, ma essenziale in
un epigramma funerario, ponendo subito all’inizio del componimento,
come nel
testo latino con versi delicati e commossi, ma il suo
stampo
era di tipo arcaizzante e con qualche vocabolo letterario ormai
disusato, come l’ “aere superno”e l’ “adre ombre”, in
cui figurava una chiara reminiscenza del sonetto Funere mersit
acerbo del
Carducci per la morte del figlioletto Dante, vv. 12-13: Oh, giù ne
l’adre/ sedi accoglilo tu, in fine di verso e in enjambement,
come nella mia traduzione. Non
mancava qualche apòcope, anch’essa ormai disusata in
poesia, anche se, devo riconoscere che, in qualche caso, come nei vv.
4-5, il troncamento accresceva col suo
suono cupo la sinistra coloritura timbrica dell’aldilà: perché
l’adre/ ombre non la riempian di paura,/ né
l’orrido trifauce can d’Averno. A quel
tempo ne ero soddisfatto, ma era cominciato intanto il mio processo di
liberazione dagli schemi letterari ottocenteschi e di apertura al
linguaggio vivo del nostro tempo, fino all’insorgere in me
di una tale insofferente reazione, che sentii l’insopprimibile bisogno
di dare una forma del tutto nuova alla versione di quell’epigramma, che
sentivo lontano, per la sua toccante semplicità, dalla mia
troppo elaborata e letteraria trasposizione, non più del tutto in
accordo col mio nuovo gusto poetico. Nacque così, per una estrema
ricerca di semplicità e di essenzialità, la seconda versione,
che apparve nel 1969 nella rivista senese “Ausonia”, diretta dal poeta
e traduttore Luigi Fiorentino (vedi in calce). Rappresentava certamente
uno stacco notevole dalla prima: nessun arcaismo, nessuna movenza
classicheggiante,
una forma sciolta e viva, con accenti teneri e intensi, molto più
vicina all’originale. Felice anche la correzione di “appunto” con
“appena”, che accentua la pietà per la tenera
età della piccola. La versione tuttavia, nata in diretta antitesi con
la prima, non rispondeva ancora in tutto all’originale: c’era ancora
qualcosa da ritoccare. Con la terza ed ultima versione, pubblicata
nel volume ”Marziale, Epigrammi”, 2013
(vedi in calce), si conclude quel lungo percorso poetico di affinamento
e adeguamento, secondo il criterio della fedeltà allo spirito e ai
valori stilistici del testo sempre da me seguito. Nell’ultima
versione ho dunque recuperato sia il nome dei genitori del poeta, sia
quello della piccola Erotio, omesso nella precedente, ma essenziale in
un epigramma funerario, ponendo subito all’inizio del componimento,
come nel
testo latino
(“Hanc...puellam”), il riferimento alla sua persona: “Questa
bambina...”. Ho dato
una nuova rappresentazione, conformemente alla nuova resa meno asciutta
dell’epigramma, del pauroso aldilà (vv. 5-6), con maggiore
aderenza ai particolari dell’originale, mantenendone i suoni cupi, in
particolare la forte allitterazione del fonema r. Ho infine sostituito
a né tu pesarle, o terra il sintagma né le sii grave,
o terra, in un più netto rapporto di
antitesi con a te fu lieve. Il lungo percorso di
affinamento e adeguamento aveva
così trovato compimento.
Questo percorso è naturalmente solo esemplificativo di quello che è
diventato, dopo le prime esperienze, il mio più
o meno immediato iter
traduttivo (anche se, in
genere, e in qualche caso in particolare, una revisione a distanza può
sempre servire). Ogni traduttore ha la sua concezione, i suoi gusti, il
suo
particolare modo di tradurre. Non si può stabilire in sede teorica un
unico modello di traduzione. Ogni traduzione, in fondo, si misura dai
suoi esiti. Per quanto mi riguarda, credo che al traduttore competa di
tradurre
il testo originale con la massima fedeltà, trasferendolo nella nuova
lingua senza farne un pedissequo duplicato, ma anche senza procedere
per vie troppo personali e divaganti. Fedeltà dunque al tono e allo
stile:
questi sono gli obiettivi ai quali mi sono sempre ispirato, oltre che
per convinzione, anche per una mia personale esigenza, che sento
soddisfatta solo quando mi sembra di avere raggiunto una sorta di
immedesimazione, di
piena consonanza con l’originale. La traduzione letteraria è
un’operazione delicata e complessa, un lavoro singolare: “scendere fino
in fondo nell’occultamento di se stesso per farsi invadere
dalla voce di un altro, farsene permeare, ma per cercare nella
profondità di se stesso un modo per restituirla. E’ un percorso di
estrema oblatività a cui fa seguito uno scatto di orgoglio creativo”
(Renata Colorni, da un’intervista di R. Reichmann). Meglio di così non
si sarebbe potuto dire.
MARZIALE,
V 34
Hanc tibi, Fronto pater,
genetrix Flaccilla, puellam
oscula commendo
deliciasque meas,
parvola ne nigras horrescat
Erotion umbras
oraque Tartarei
prodigiosa canis.
impletura fuit sextae modo
frigora brumae,
vixisset totidem ni
minus illa dies.
inter tam veteres ludat
lasciva patronos
et nomen blaeso
garriat ore meum.
Mollia non rigidus caespes
tegat ossa nec illi,
terra, gravis
fueris: non fuit illa tibi.
(testo latino a cura di W.M.
Lindsay, Oxford 19292, rist. 1969)
TRADUZIONI
EPICEDIO PER EROTIO
Padre
Frontone, e tu, Flaccilla madre,
della bambina
Erotio abbiate
cura,
ch’era mio vezzo e
gioia,
perché l’adre
ombre non
la riempian
di paura,
né l’orrido
trifauce can
d’Averno.
Oggi avrebbe la
povera creatura
compiuto
appunto il
sesto freddo inverno,
se il Ciel le
avesse dato di
restare
altri sei giorni a
l’aere
superno.
Oh ma che
possa ancor,
tra voi, giocare
felice come a
l’aura serena
e con incerta
lingua
cinguettare
il nome
mio! Non dura
zolla prema
le delicate ossa,
né tu grave
esserle, o terra:
lei ti
sfiorò appena
(da “Gymnasium”,
1961-62, p.
424)
A voi, miei
genitori,
raccomando
questa bambina,
che era la mia
gioia,
perché al buio del
Tartaro e
alla vista
del cane mostruoso
ella non
tremi.
Oggi avrebbe la
povera piccina
compiuto appena il
sesto
freddo inverno,
se altri sei dì
fosse rimasta
in vita.
Tra i cari suoi
patroni possa
ancora
giocar felice e
con la
malsicura
vocina cinguettare
il nome mio!
Non dura zolla le
molli ossa
copra,
né tu pesarle, o
terra: a te
fu lieve.
(da
“Ausonia”, A. XXIV,
Genn. – Febbraio 1969)
Questa bambina,
che era la mia
gioia,
l’amore mio, a te,
padre
Frontone,
a te, madre
Flaccilla,
raccomando,
perché la piccola
Erotio non
abbia
orrore delle nere
ombre e del
cane
tartareo dalla
gola mostruosa.
Oggi avrebbe la
povera piccina
compiuto appena il
sesto
freddo inverno,
se altri sei dì
fosse rimasta
in vita.
Tra i cari suoi
patroni possa
ancora
giocar felice e
con la
malsicura
vocina cinguettare
il nome mio!
Non dura zolla le
molli ossa
copra,
né le sii grave, o
terra: a te
fu lieve.
(da “Marziale, Epigrammi” , introduzione,
traduzione e note di Pietro Rapezzi, Quattroventi, Urbino 2013).
2.
NOTA ALLA TRADUZIONE
DELLE
Dopo
tante disquisizioni e teorizzazioni sulla traduzione, si finisce sempre
per tornare al punto di partenza: non esiste un tipo di traduzione che
sia il migliore di tutti e proponibile a modello. Non esiste la
traduzione in astratto: esistono i singoli poeti e i singoli testi da
tradurre. Non a tutti i poeti si confà lo stesso sistema di traduzione,
anche se nessun sistema può essere in partenza categoricamente escluso.
Ciascun poeta pone dei problemi specifici. Alcuni sono quasi
intraducibili per certi caratteri che solo nella lingua originale
trovano il loro pieno valore. L’Orazio delle Odi è uno
di questi. La composizione in strofe di raffinata e variegata
struttura, intessuta di stilemi originali, associazioni ardite,
concentrazioni espressive le rende dei
modelli poetici molto problematici da tradurre.
Rendere in italiano il rapporto armonico e funzionale che c’è tra
metro, strofa, verso e spirito dell’ode è un obiettivo forse
irraggiungibile. La difficoltà del compito non deve tuttavia dispensare
dall’affrontarlo, rinunciando a trasferire nella nostra lingua almeno
dei riflessi di quella poesia. Tradurre, quando non lo si faccia per
mestiere, oltre che una vocazione e un atto di amore, è una ricerca,
un’analisi, un contributo alla ricognizione del testo. Presento
pertanto, a titolo di sperimentazione e ben consapevole della distanza
dal modello, cinque traduzioni affrontate con metodi diversi,
limitandomi da parte mia a fare qualche osservazione a chiarimento
delle modalità seguite.
Le
odi tradotte sono: I 4; 9; II 3; 14; IV 7: le tre centrali costituite,
nell’originale, da strofe alcaiche1, la prima e l’ultima da metri
archilochei, rispettivamente quarto e primo (ma
esistono altre classificazioni dell’archilocheo)2.
Nelle traduzioni italiane mi sono servito di modalità abbastanza
difformi. Per l’alcaica ho usato: il metodo “barbaro” dell’accento
ritmico, contaminandolo con varie licenze del metodo barbaro
carducciano o grammaticale (II 3)3;
il metodo che, stando ai criteri di classificazione del Vergara,
potrebbe definirsi dell’approssimazione (I 9)4;
l’endecasillabo sciolto (II 14). Per l’archilocheo (I 4; IV 7) ho
usato il verso libero secondo due differenti modalità.
Comincio con la
traduzione dell’ode II 3 (Aequam memento rebus in arduis),
fondata sul metodo ritmico ‒
consistente, come è noto, oltre che nella corrispondenza, comune a
tutta la poesia barbara, del numero delle
sillabe di ciascun verso italiano con quelle dell’analogo verso latino,
nella coincidenza degli accenti tonici italiani con le arsi dei versi
classici ‒, ma con varie
concessioni al metodo grammaticale. La strofa italiana ha assunto
pertanto la seguente configurazione formale: vv. 1-2: due doppi
quinari, di cui il primo piano, il secondo sdrucciolo, con cesura
sempre dieretica tra i due emistichi; v. 3: un novenario piano; v. 4:
un decasillabo piano. Per quanto riguarda l’accentazione, mentre il
sistema ritmico è stato sempre osservato nei versi 3 (di ritmo
giambico, con accenti di 2^, 4^, 6^, 8^) e 4 (di ritmo
dattilico-trocaico, con accenti di 1^, 4^, 7^, 9^), nei primi due versi
si è temperata talvolta la rigidezza del metodo ritmico col più
elastico metodo carducciano. In particolare nel secondo quinario
l’accento di prima sede lascia frequentemente il posto a quello di
seconda, mentre anche nel primo quinario, ma solo rare volte, manca
l’accento di seconda sede. Tale contemperamento è stato determinato da
ragioni poetiche, anteposte alla rigida applicazione della regola. Devo
infatti rilevare che, in tale tipo di versificazione, la dura
costrizione metrica rende talvolta molto limitativo l’atto
della ricreazione poetica. Altra cosa è usare un certo tipo di metrica
con le sue specificità, anche se vincolanti, in una composizione
originale, che si svolga in piena libertà creativa, altra cosa
finalizzarlo al rifacimento d’un testo con una
sua struttura già definita, a cui debba
risultare “fedele”. Insomma una cosa è scrivere in proprio, un’altra
tradurre, che è una specie di “libertà vigilata”. Si rischia di
rimanere imprigionati in schemi formali, senza riuscire ad animare e ricreare la versione dall’interno. Mantenere
inalterato il numero dei versi e quello delle sillabe, in due lingue
tanto diverse, è già di per sé un’operazione difficile: riprodurre
insieme la poesia, il tono e lo stile, sempre in quella medesima
strettoia, è ancora più arduo. Per questo
tipo di traduzione il pericolo maggiore è di approdare a soluzioni
tecnicamente ineccepibili, ma poeticamente morte. Bisogna poi dire che
tale corrispondenza ritmica è qualcosa di illusorio, non potendo
offrire che una mera parvenza di quella che doveva essere l’armonia del
verso fondata sulla quantità, oggi non più percepibile.
Per
la traduzione dell’ode I 9 (Vides ut alta stet nive candidum), ho dato maggiore estensione al verso con l’uso
generalizzato dell’endecasillabo, ma
mantenendo anche qui, anche se in modo imperfetto, l’andamento ritmico
proprio dell’alcaica. Il leggero allungamento del verso è bastato a
facilitare la traduzione, consentendo maggiore libertà espressiva e la
possibilità di aderire al testo con maggiore naturalezza.
L’endecasillabo alcaico è stato reso con un endecasillabo sdrucciolo
sempre introdotto da un quinario piano, per lo più con cesura
dieretica, così da rendere sensibile lo stacco tra i due membri.
L’enneasillabo del terzo verso, anche se nella versione accresciuto di
due sillabe, ha mantenuto generalmente la scansione giambica, mentre
anche nel decasillabo finale ho conservato
l’incipit dattilico con
accenti di 1, 4, 7, 10.
Niente
è necessario dire a proposito dell’endecasillabo sciolto, con
cui è stata resa l’ode II 14 (Eheu fugaces, Postume, Postume).
Poco
c’è da dire, almeno in questa sede, anche a proposito del verso libero,
che consente ovviamente ampie possibilità di intervento, anche se
sostanzialmente riconducibili a due fondamentali modalità: una
consistente nel dare alla traduzione una nuova struttura, più vicina al
carattere della poesia italiana, che possa confrontarsi negli esiti con
l’originale; l’altra tendente invece a dare alla traduzione una specie
di equivalenza strutturale, mantenendo gli stessi versi dell’originale
e traducendoli “verso da verso”, col massimo di aderenza a ciascuno. Io
ho usato ambedue le modalità.
Ai
lettori il giudizio.
_____________________
1.
L’alcaica è una strofa tetrastica, formata da due endecasillabi alcaici
(tripodia giambica catalettica più dipodia dattilica con cesura
dieretica tra i due cola), un enneasillabo alcaico
(pentapodia giambica catalettica) e un decasillabo alcaico (dipodia
dattilica più dipodia trocaica).
2.
Si tratta comunque, per quanto riguarda I 4, di
una strofa distica costituita da un archilocheo maggiore (tetrametro
dattilico più tripodia trocaica con cesura
dieretica tra i due cola), seguito
da un trimetro giambico catalettico; per
quanto riguarda IV 7, di una strofa distica costituita da un esametro
dattilico seguito da una tripodia dattilica catalettica in
syllabam. Secondo una teoria risalente al filologo tedesco August
Meineke, non da tutti condivisa, ambedue le strofe distiche sarebbero
sempre usate in coppia nelle Odi, così da diventare
anch’esse delle strofe tetrastiche.
3.
La definizione di poesia
“barbara”, coniata dal Carducci, è meglio applicarla, come scrive G.
Vergara, La poesia barbara: come e quando, “Misure critiche”, A. VI, n. 18,
gennaio-marzo 1976, pp. 73-74; ID., Guida allo studio
della poesia barbara italiana, Napoli 1978, p. 12, in modo da
evitare confusioni, a “tutta la produzione
poetica di imitazione latina e greca”, distinguendola però di volta in
volta con delle aggiunte che ne specifichino i diversi principi cui si
attiene. Abbiamo così, seguendo tale criterio: “1) poesia barbara della
quantità (metodo prosodico o del Tolomei); 2) poesia barbara
dell’accento grammaticale (metodo
barbaro o del Carducci); 3) poesia barbara dell’accento ritmico (metodo
ritmico o del dopo-Carducci); 4) poesia barbara dell’accento ritmico e
della quantità (metodo ritmico-prosodico o del Pascoli); 5) poesia
barbara dell’approssimazione”.
4.
Il Vergara definisce poesia dell’approssimazione quella che tende, sul
piano metrico, ad “una approssimativa imitazione dei versi classici”,
riproducendone “aspetti marginali”, La
poesia barbara cit.,
p. 74.
|

![]()
 Cliccando sul bottone hai
questa pagina in formato stampabile o in pdf
Cliccando sul bottone hai
questa pagina in formato stampabile o in pdf